a cura del Prof. Pasquale Mancino
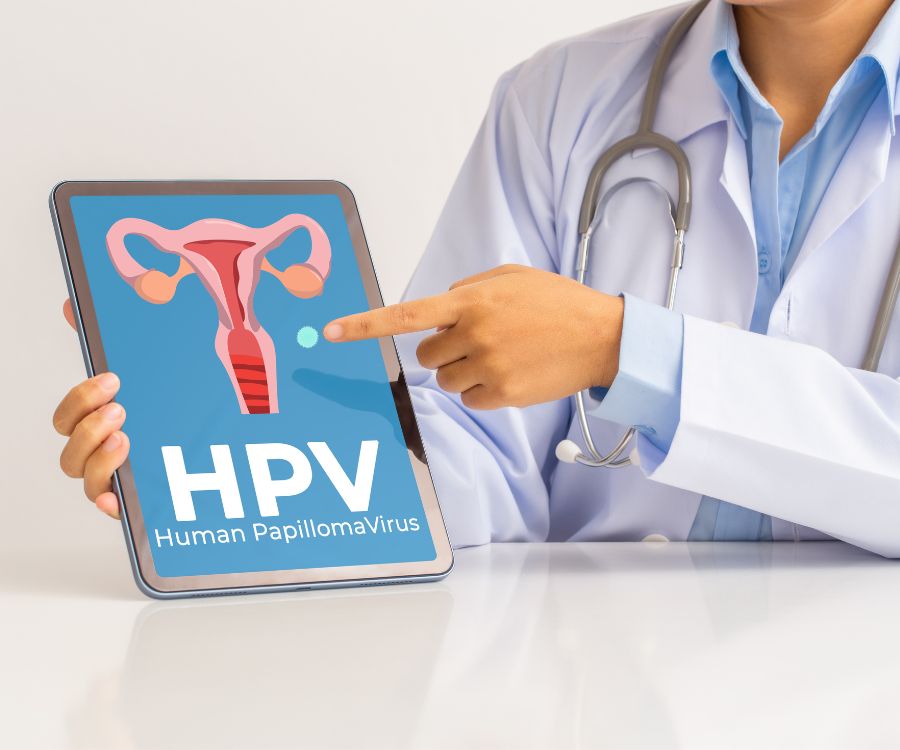
Oggi affrontiamo un argomento che riguarda molte donne, un problema doloroso e spesso trascurato: la dismenorrea. Spesso classificata come un normale disagio mestruale, la dismenorrea va ben oltre un semplice disturbo.
Può influenzare profondamente la vita quotidiana, la produttività lavorativa, e la salute emotiva. Nelle prossime righe, esploreremo insieme cosa sia la dismenorrea, le sue cause, i sintomi e le opzioni di trattamento, sia convenzionali che naturali.
1. Cos’è l’HPV (Papillomavirus)
Il Papillomavirus, anche conosciuto come HPV, è il virus responsabile dello sviluppo di diverse tipologie di tumori, non soltanto femminili. È infatti correlato alla comparsa di circa il 95-97% dei tumori del collo dell’utero (o cervice), ma è implicato anche nel circa 85% dei tumori dell’ano, nel 50% dei tumori del pene, nel 40% dei tumori della vagina e nel 30% dei tumori dell’orofaringe.
Genotipi e rischi associati
Se ne riconoscono diverse tipologie, definite genotipi, classificate come “a basso rischio” e “ad alto rischio”, in relazione alla loro capacità di determinare lo sviluppo di lesioni pre-tumorali e tumorali.
I genotipi “a basso rischio”, principalmente HPV 6 e HPV 11, sono tipicamente responsabili della comparsa di lesioni benigne come le verruche cutanee e i condilomi delle mucose genitali, delle escrescenze dalla superficie irregolare che tendono ad ingrandirsi e a confluire nel tempo.
I genotipi “ad alto rischio”, quali HPV 16 e HPV 18, sono invece correlati a circa il 70% dei casi di carcinoma della cervice, insieme ad HPV 31, 33, 45, 52 e 58.
Diffusione e trasmissione dell’HPV
Il Papillomavirus è un virus ampiamente diffuso su scala mondiale e gran parte della popolazione sessualmente attiva, sia maschile che femminile, entra a contatto con esso durante la propria vita. Quest’ultimo si contrae generalmente con l’inizio dell’attività sessuale tramite il contatto, non solo penetrativo, tra cute e mucose.
Nella maggior parte dei casi si determina un’infezione asintomatica, che regredisce spontaneamente entro circa due anni dalla sua insorgenza. La guarigione spontanea può essere comunque influenzata da fattori come il genotipo e lo stile di vita.
La persistenza del virus, soprattutto dei ceppi 16 e 18, è invece associata alla comparsa di lesioni pre-cancerose e cancerose.
Il cancro cervicale è oggi il quarto tumore femminile più comune a livello mondiale e una delle cause di morte correlata a tumore più frequente. Ciò nonostante, si può prevenire ed è curabile se precocemente individuato e trattato nel modo migliore.
2. Prevenzione e vaccinazione contro l’HPV
L’importanza della vaccinazione
Per proteggere la popolazione dalle patologie e dai tumori HPV-correlati, disponiamo di diverse strategie, che prevedono la vaccinazione, lo screening e il trattamento precoce delle lesioni.
L’unico metodo di prevenzione primaria (ovvero l’unico metodo che permette di non contrarre l’infezione pur venendo a contatto con il virus) è la vaccinazione. Contrariamente a quanto succede per altre infezioni sessualmente trasmesse, l’utilizzo del profilattico riduce infatti la possibilità di contagio ma non la elimina mai del tutto, dal momento che il virus si localizza anche a livello delle zone non protette come la vulva, l’ano e lo scroto.
La massima efficacia della vaccinazione viene raggiunta quando quest’ultima si esegue in età adolescenziale, ovvero prima dell’inizio dell’attività sessuale. Ciò nonostante, può essere comunque eseguita fino ai 45 anni, dopo un’adeguata valutazione con il proprio medico del rapporto costo-beneficio.
La vaccinazione è inoltre consigliata anche a tutti quei soggetti che sono stati trattati per lesioni da HPV, dal momento che è stato dimostrato che tale pratica riduce i tassi di recidiva. Viene inoltre indicata anche al sesso maschile, in modo tale da ridurre la circolazione del virus nella popolazione generale e da proteggere anche gli uomini dai tumori HPV-correlati.
Tipologie di vaccino e raccomandazioni
Ad oggi sono disponibili tre tipologie di vaccino anti-HPV (quadrivalente, bivalente e nonavalente) ma tutte svolgono un’azione protettiva nei confronti dei genotipi HPV 16 e 18, che da soli sono responsabili di almeno il 70% dei tumori del collo dell’utero.
Quella attualmente più utilizzata è la nonavalente, perché include i ceppi ad elevato rischio oncogeno più diffusi (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58). Nelle diverse regioni sono stati approvati differenti piani di accessibilità gratuita alla vaccinazione.
Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 raccomanda la vaccinazione anti-HPV:
- nel dodicesimo anno di vita per tutta la popolazione (femminile e maschile);
- nelle donne al 25° anno di età, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP-test);
- nei soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni (Men who have Sex with Men – MSM).
Nel calendario vaccinale sono previste:
- due dosi se la somministrazione è eseguita fra gli 11 e i 14 anni, a distanza di 6 mesi l’una dall’altra;
- tre dosi (a 0, 2 e 6 mesi) se la somministrazione è eseguita dopo i 14 anni. La seconda dose deve essere somministrata ad almeno 1 mese dalla prima e la terza ad almeno 3 mesi dalla seconda dose, concludendo il ciclo completo in 1 anno.
3. Metodiche di prevenzione secondaria: PAP test e HPV DNA test
Come metodiche di prevenzione secondaria sono, ad oggi, disponibili il PAP test e l’HPV DNA test, che consentono di individuare tutte quelle donne con lesioni pre-cancerose, ovvero più a rischio di sviluppare un tumore, e di sottoporle ad esami più approfonditi.
Il PAP test: cos’è e come funziona
Il PAP test, o test di Papanicolau dal nome del suo inventore, è un esame generalmente indolore che si svolge durante una visita ginecologica di routine. Il medico che lo esegue posiziona uno speculum, ovvero lo strumento che permette di visualizzare il collo dell’utero, e preleva con due piccole spatole le cellule esterne ed interne del collo dell’utero, che poi vengono poi alternativamente depositate su un vetrino e fissate o inserite all’interno di una soluzione in grado di preservarle.
Il materiale così prelevato viene poi analizzato in laboratorio da personale esperto, al fine di individuare eventuali trasformazioni delle cellule indotte dal Papillomavirus. È necessario attendere un tempo variabile a seconda dal laboratorio i cui è studiato il campione per ricevere il risultato.
Per effettuare il PAP test non è necessaria alcuna particolare preparazione ma sono richieste alcune accortezze come:
- l’assenza di perdite di sangue;
- l’astensione dai rapporti sessuali nei due giorni prima del test;
- non utilizzare, nei tre giorni precedenti, ovuli, creme o lavande vaginali.
La gravidanza, l’utilizzo di contraccettivi orali (pillola) o dispositivi intrauterini (spirale) non è una controindicazione all’esecuzione del PAP test.
L’HPV DNA test: caratteristiche e indicazioni
L’HPV DNA test viene eseguito con le stesse modalità ma il materiale prelevato viene studiato alla ricerca del DNA del virus e non delle cellule trasformate. Sono indicate le stesse accortezze da utilizzare prima dell’esecuzione del PAP test.
Programmi di screening e tempistiche
Prima dell’avvento dell’HPV DNA test, il programma di screening prevedeva l’esecuzione di un PAP test ogni 3 anni dai 25 ai 64 anni, in caso di persistente negatività dell’esame.
Il nuovo programma di screening prevede, invece, l’esecuzione di un PAP test dai 25 anni ai 30-35 anni ogni 3 anni, sostituito poi dai 30-35 anni dall’HPV DNA test ogni 5 anni, nel caso di persistente negatività dell’esame.
Le tempistiche sopra indicate possono variare a seconda del caso clinico e a discrezione del medico curante. Per il partner maschile non è indicata l’esecuzione dell’HPV DNA test e nessun trattamento è richiesto a meno di lesioni evidenti.
La positività all’HPV DNA test non dovrebbe generare ansia e paura nella donna; se eseguito prima dei 25 anni perché l’infezione, con molta probabilità, andrà spontaneamente in regressione, se eseguito dopo i 25 anni perché la sola infezione non è sinonimo di patologia.
4. Diagnosi e monitoraggio delle lesioni da HPV
Le donne con HPV DNA test positivo possono e devono continuare a svolgere una vita, anche sessuale, normale, programmando, in accordo con il proprio medico, i controlli successivi.
Qualora l’HPV DNA test risultasse positivo, le donne vengono infatti invitate a sottoporsi all’esecuzione del PAP test, al fine di individuare tutte coloro che, venute a contatto con il virus, a causa della sua persistenza hanno sviluppato lesioni precancerose.
HPV DNA test e PAP test possono essere eseguiti con tempistiche diverse, anche nel corso della stessa visita, a discrezione del medico.
La colposcopia: un esame non invasivo
Nel caso di positività al PAP test è possibile eseguire un ulteriore esame denominato colposcopia. La colposcopia è un esame non invasivo che, grazie ad uno strumento simile ad un microscopio, permette di osservare ad un maggiore ingrandimento i genitali esterni, la vagina e la cervice.
Il ginecologo o la ginecologa, dopo aver osservato attentamente i genitali, posizionano lo speculum e osservano il collo dell’utero con l’utilizzo di alcuni coloranti, in grado di mettere in evidenza lesioni anche non visibili ad occhio nudo.
Questo esame permette, se necessario, di eseguire piccoli prelievi di tessuto mirati (biopsie) e di monitorare il quadro dell’infezione nel tempo, grazie al referto accurato in cui vengono descritte la tipologia e la posizione delle lesioni presenti.
L’importanza della diagnosi precoce
Individuare lesioni, tramite questi esami di screening, è da considerarsi una vittoria personale e per la sanità pubblica.
In questo modo è infatti possibile trattare precocemente delle alterazioni che, ignorate, potrebbero degenerare in quadri molto più severi come il carcinoma della cervice, di grande impatto sulla vita della singola donna e della società.
Qualora doveste ricevere queste tipologie di diagnosi, il medico vi suggerirà la migliore strategia di trattamento e di follow-up.
Bibliografia
- Aiom, Airtum, I numeri del cancro in Italia. Edizione 2022. Disponibile online: https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2022/12/2022_AIOM_NDC-web.pdf.
- Plummer M, Franceschi S. Strategies for HPV prevention. Virus Res. 2002;89(2):285-293. doi:10.1016/s0168-1702(02)00197-1
- Bruni L, Albero G, Serrano B, Mena M, Collado JJ, Gómez D, Muñoz J, Bosch FX, de Sanjosé S. ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in the World. Summary Report 10 March 2023. [Date Accessed]
- Calabrò GE, Carini E, Favaretti C, Bonanni P. De Vincenzo R, Ghelardi A. et al. Report di approfondimento e valutazione, con metodologia HTA (Health Technology Assessment), della vaccinazione anti-HPV nelle donne trattate per lesioni HPV-correlate. QIJPH – 2019, Volume 8, Number 7. Disponibile online: https://www.ijph.it/pdf/2019-v8-n7.pdf
- Ministero della Salute. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019. 17 gennaio 2017.Disponibileonline: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
- Joura EA, Kyrgiou M, Bosch FX, et al. Human papillomavirus vaccination: The ESGO-EFC position paper of the European society of Gynaecologic Oncology and the European Federation for colposcopy. Eur J Cancer. 2019;116:21-26.
- Gisci, Indicazioni per il prelievo nello screening del carcinoma cervicale. Edizione 2016. Disponibile online: https://gisci.it/documenti/documenti_gisci/PRELIEVO2016.pdf
Disclaimer: articolo a contenuto divulgativo che non ha valenza di consultazione clinica, per ogni caso specifico è necessario rivolgersi al proprio Medico.

A cura di:
Prof. Pasquale Mancino
Specialità:
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Biografia:
Dirigente 1° livello Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Università “La Sapienza” Roma
Docente Corso di Laurea in Ostetricia










